Uomini, Pecore e Lupi
- Guido Freddi-Poswick
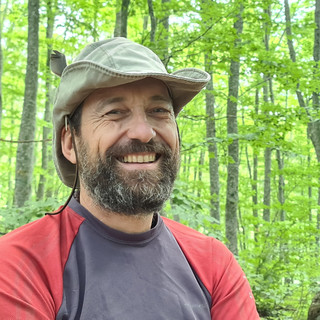
- 19 feb 2023
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 20 feb 2025
escursione immaginaria in 10.000 anni di storia e mito

Non tanto tempo fa stavo contemplando il tramonto a Camposecco. Contravvenendo alle giuste regole dei Parchi avevo portato con me il cane. Sarei rimasto via da casa per alcuni giorni e nessuno avrebbe potuto occuparsi di Zigotò. A discolpa mi dissi che non è un cane cittadino, che vive con me in campagna e che le sue zampe calpestano tutti i giorni lo stesso territorio di volpi, tassi, lupi, cinghiali e altri mammiferi. E che comunque avevo deciso di restare sulla carrareccia da dove potevo tranquillamente fare le foto che mi interessavano. Inquadrando il bestiame brado nella luce arancione tagliata dalle forme dei pendii circostanti, vidi dietro a delle rocce un giovane lupo solitario di pelo molto scuro, quasi nero, che stava facendo la posta a dei vitelli. Quando la mandria di bovini se ne accorse e cominciò a minacciarlo con le corna basse il lupo si allontanò, trotterellando senza fretta. Il mio cane, un selvatico barboncino nano bianco sporco, pensò bene (male) di seguirlo, sfuggendomi come non fa mai. In pochi attimi i due scomparvero nella faggeta oramai troppo buia per vedere che fine avessero fatto. Mi aspettavo di sentire da un momento all’altro l’acuto “kai!” di un cagnolino che crede di essere un maremmano ma sembra piuttosto un agnello. Invece dopo qualche minuto Zigotò tornò, trotterellando come sanno fare solo i lupi. “Mai più nei Parchi” pensai, ma la faccenda mi rimase in testa fino ad oggi.
Tutto sembrò cominciare…
…10.000 anni fa, quando, non lontano dalle rive del Mediterraneo furono domesticate le pecore.
Era la rivoluzione neolitica. Prime rudimentali forme di agricoltura si erano sviluppate nei secoli precedenti e con l’allevamento esse permisero ai popoli anatolici (originari dell’odierna Turchia) di emanciparsi dalla caccia e dalla raccolta come

attività di sussistenza.
Qualcosa nel clima era cambiato. Da secoli i ghiacciai continuavano a ritirarsi. La vecchia economia di sussistenza incentrata sulla caccia ad immense mandrie di grandi mammiferi non era più possibile. Molti animali, adattatisi per millenni al freddo e ai grandi spazi, erano costretti a cambiare abitudini, a migrare sempre più a Nord verso il circolo polare artico, o a estinguersi.
Lì dove c’era la tundra ora crescevano foreste. I grandi spazi che favorivano il nomadismo gradualmente si chiudevano tra foreste immense.
Un’era tramontava, ma nuove risorse si manifestavano per chi aveva l’intelligenza di adattarsi: l’abbondanza di acqua che sgorgava dal terreno allo stato liquido creando fiumi e laghi, il legno in quantità e varietà mai viste prima... erano cresciute nuove foreste che potevano sostenere una densità di risorse mai vista prima a memoria d'uomo. La terra ora era scongelata, morbida, umida e manipolabile.
Rapidamente il popolamento umano aumentò e con esso anche la pressione demografica. In un ambiente sempre più antropizzato fu necessario creare nuovi stili di vita di crescente complessità sociale. La segmentazione in gruppi di età e di genere e la specializzazione di alcuni gruppi di individui permisero di rilasciare, all’interno dello stesso clan, le energie necessarie al fiorire delle prime forme di agricoltura e allevamento.
10.000 anni fa dall’altopiano anatolico gruppi neolitici “rivoluzionari” iniziarono ad espandersi nell’Eurasia fino a raggiungere la Sicilia.
Dall’Anatolia all’Italia…
…popoli del vicino oriente giunsero 6.000 anni fa attratti inizialmente dall’ossidiana di Lipari. Le nuove tecniche di sussistenza e le nuove tecnologie messe a punto nel vicino oriente si rivelarono imbattibili per i cacciatori e raccoglitori dell'italia neolitica.
La pastorizia fu, tra le tecniche di sopravvivenza appena sbarcate, quella che più facilmente si impose nella penisola italica, forse grazie ad un ambiente naturale non troppo dissimile dall’Anatolia occidentale.

Per 4.500 anni l’allevamento ovo-caprino fu praticato dalle coste marine fino alle montagne e vide fiorire la cultura Appenninica.
Poi durante l’età del Bronzo si insediarono in Italia popoli indoeuropei proveniente dal territorio austro-bavarese in un processo di graduale integrazione con i popoli appenninici. Un processo probabilmente non traumatico che fiorì nella...
…cultura Villanoviana.
Questo periodo di dominante attività pastorale (sebbene l’agricoltura fosse anche ben sviluppata lì dove vi erano condizioni particolarmente favorevoli), fu una fase ricca di interscambi materiali e culturali dell’Italia con le civiltà Fenicia e soprattutto Micenea.
La creazione e la difesa di colonie costiere greche e fenicie richiedeva una tecnologia marina molto avanzata e degli approdi ben riparati e difendibili. Mentre i fenici erano sostanzialmente concentrati sull’attività mercantile, i micenei continuavano a non disdegnare attività “piratesche” e di conquista di posti strategici per il controllo delle rotte. Al culmine del processo di espansione micenea il Mediterraneo era un campo di gioco tra loro ed i fenici ormai incentrati a Cartagine. Il collasso della cività micenea avvenne quando il bronzo iniziò ad essere sfidato dal ferro, e si concretizzò nell’assedio di Troia. Questo assedio fu ritenuto fin da subito una pessima idea da…
…Ulisse l’arguto…
…restio a questa scelta storica imposta da Agamennone, il primus inter pares, il re dei re micenei, guerra che a colui che più di altri forse era in contatto con i mercanti micenei, appariva prevedibilmente costosissima in termini di risorse umane e tempo. Ulisse re di Itaca, re dell’avamposto occidentale della Grecia micenea, molto più interessato al commercio con la penisola Italica e al controllo delle rotte del Mediterraneo occidentale, tentò invano di evitare di partire per Troia.
La storia dimostrò che Odisseo non ebbe torto: la vittoria achea contro Troia fu una vittoria di Pirro. Qualche decennio dopo, alla fine del secondo millennio, l’intera civiltà micenea collassò.
Ormai l’età del bronzo e del culto eroico era tramontata. La Grecia sprofondò in tre secoli di barbarie. Le colonie micenee nel Tirreno persero contatto con la madrepatria e diventarono rifugio per i micenei in fuga dal medioevo greco. Questi difficili viaggi divennero archetipi di miti epici di fondazione come quello di Enea, fuggito da Troia e sbarcato nel Latium.
Lungo le coste cominciarono ad imporsi nuovi modelli e nuovi arrivati, co-fondatori di civiltà come quella etrusca e quella romana.
La lupa di Roma…
…segnò un nuovo archetipo di coesione e differenziazione sociale espresso nel mito di Romolo e Remo. Essa nutrì sia il nomade che il sedentario, i due capostipiti di stili di vita complementari e divergenti, separati da un solco sacro e inviolabile.
Proviamo ad immaginare quel giorno:
Romolo si guardò intorno. Qui, sul colle dominante il Tevere, avrebbe costruito una città come Micene, come Troia, come quelle descritte da Enea e gli Achei, fuggiti nel Latium da una Grecia collassata nella barbarie.
Il solco quadrato era completo, il colle Palatino era suo, solo suo. Romolo chiuse gli occhi, guardò indietro al proprio passato, quando lui ed il fratello Remo erano in balìa degli dèi della natura. Qui sarebbe stato al sicuro, si disse, ma sentì che nel quadrato che aveva solcato mancava qualcosa, mancava un elemento essenziale all’equilibrio interno del microcosmo appena creato, qualcosa di libero e selvaggio.

Per difendere il suo sogno di sicurezza e di dominio sulla Natura aveva dovuto uccidere suo fratello Remo, il fratello pastore. Remo era convinto che la terra non potesse essere spartita, divisa, tagliata come un agnello. Ora però Romolo si rendeva conto che nel suo sogno di città mancava il mondo selvaggio, il pastore, l’energia del lupo e del suo opposto, l’energia indomabile con cui Remo osò passare il solco, violare quel sogno a costo di perdere la vita.
Romolo fu preso da un tremore di pietas. Il fratello aveva bisogno del fratello. Il cittadino aveva bisogno del pastore. Remo doveva restare qui, pensò, nel solco del vallo sul colle Palatino. Lo avrebbe sepolto con tutti gli onori sotto la pietra angolare di Roma. Non solo, a fargli compagnia, nella grotta di tufo ai piedi delle falde scoscese del Palatino avrebbe tenuto una lupa che ogni cittadino avrebbe dovuto onorare con dei lupercalia. La lupa sarebbe diventata il nume tutelare della città e il pastore nume tutelare delle sue mura, rendendo Roma sacra ed eterna come fino ad allora lo era stata solo la Natura.
Natura dissacrata
Secoli dopo la fondazione di Roma, sulla scia di un solco dissacratore, la terra venne frammentata in piccole “proprietà” a conduzione famigliare. Essa non fu più sacra come una Grande Madre selvaggia e sconfinata su cui pascolare mandrie, ma sacra come un elemento geografico chiuso, preciso, squadrato, monumentale, non più sacralizzata dal tuono e dagli astri, ma sacralizzata invece dal re/sacerdote, accudita non più dal lupo ma dalle usurpatrici vestali. Questa “proto-privatizzazione” della terra respinse la pastorizia fuori dalle mura e dai valli.
In pianura a quell’epoca si affermarono agricoltura e bestiame di corte, poi a partire dalla Roma repubblicana iniziò ad imporsi la centuriazione e infine il latifondo.
La terra perse il valore sacro per acquisire quello di commodity, un bene qualunque che poteva essere comprato e venduto, espropriato e riassegnato. La conseguenza fu che la pastorizia, con il suo bisogno di libero movimento delle greggi, divenne un’attività prevalentemente “di montagna”.
È in questa forma montana che il mestiere di pastore si è mantenuto fino ai nostri giorni. Nell’Appennino persone come Mariano continuano a praticare la monticazione stagionale con l’aiuto dei famosi cani abruzzesi, fondamentali non solo per mantenere unito il gregge, ma anche per tener lontano il lupo.
In realtà tutto cominciò…
…14.500 anni fa, molto prima della pastorizia! Alcuni branchi di lupi probabilmente iniziarono a profittare delle ecatombi compiute dagli umani nei confronti dei grandi mammiferi iniziando a fare sciacallaggio e finendo per collaborare in queste cacce difficili e pericolose ma energeticamente convenienti. Fu così che cane e lupo si diversificarono dall’antenato comune, pur sempre figli di una stessa lupa archetipa.

Per millenni i due canidi fratelli, proprio come Remo e Romolo, continuarono a seguire due strategie di sopravvivenza diverse: liberi e temerari i lupi, stanziali e collaborativi con l’uomo i cani.
La pastorizia diede ai cani un nuovo ruolo: non più di circondare le prede che gli uomini avrebbero ucciso, ma di circondare greggi per proteggerle dall’avversario di sempre, il lupo. D’altronde i lupi, animali intelligenti almeno quanto i cani, presto capirono che le pecore, per quanto accudite, erano prede possibili quanto i cervi o i cinghiali e che tutto sommato questi pastori più che un problema rappresentavano una risorsa.
Un mondo epico
Questo equilibrio dinamico tra cane e lupo rappresenta una delle più belle ed epiche relazioni tra l’uomo e la natura, tra civiltà e mondo selvaggio.
Lì fuori, nascosto in impenetrabili faggete, esiste ancora oggi un essere libero e capace di sfidare la civiltà, ed è proprio questa sfida, questo spauracchio, questo lupo mannaro a farci accettare i nostri metaforici guinzagli, i nostri più concreti recinti, le costrizioni e frustrazioni che assumiamo volontariamente pur di tenere lontano il "Lupo".
Senza la paura del lupo potremmo improvvisamente rinunciare alle mura di pietra e cemento, potremmo liberarci da molte delle regole che incanalano le nostre scelte, potremmo liberarci dal pregiudizio verso il diverso, il selvaggio, l'arcaico, il biologico.

La civiltà ha fatto del lupo un criminale assetato di sangue, un mostro che va tenuto a distanza: è la paura ciò che meglio giustifica mura e recinzioni e grazie a tali artifici la terra può essere dissacrata e resa commerciabile.
Eppure il lupo è anche nostro fratello Remo, sacrificato e immortalato nelle fondamenta stesse della civiltà.
Per questo, malgrado tutto, il lupo è ammirato per il coraggio e l’indipendenza, per l’astuzia e la discrezione, per l’affettuosità verso la prole e la socialità verso il gruppo.
Simboli, poemi, miti e opere d’arte…
…hanno trasformato il lupo in un potentissimo archetipo che riposa nel profondo della nostra mente, sempre vigile. Il Lupo non il cane, l’avversario non il servo ha ispirato artisti e condottieri. Malgrado l’affetto profondo che lega l’uomo e il suo cane nel quotidiano, solo il lupo è capace di riportare l’uomo nel mondo straordinario della natura indomita. Anzi, dare del "cane" a qualcuno è un insulto. Probabilmente l’uomo ha bisogno di entrambi: dell’affettuosa semplicità del cane e della misteriosa libertà del lupo.
Dopo secoli di conflitti però il lupo ha iniziato a soccombere. I veleni, i fucili, le trappole hanno permesso all’uomo di farlo sparire da ogni angolo d’Europa.
Ogni angolo? Non esattamente. Proprio qui nell’Appennino centrale, nei monti di San Francesco, alle porte di una Roma nata da una lupa…
…qualcosa di straordinario è successo:
Spinto sull’orlo dell’estinzione il lupo è stato salvato dal suo avversario.
L’uomo ha guardato indietro al proprio passato e, come il suo antenato mitico Romolo, ha visto che mancava qualcosa, qualcosa di libero e selvaggio, di determinante nell’equilibrio interno di un ambiente ormai antropizzato. Mancando il lupo mancava qualcosa che dava ispirazione a santi, poeti ed esploratori e anche a semplici amanti della natura.
Il lupo non è mai stato solo un mostro mangia bambini. Ha ispirato pitture rupestri, danze, canti e dato nome a divinità ed eroi presso popoli di tutto il mondo. Il lupo è uno dei simboli più potenti della nostra energia primaria, un elemento archetipo universalmente presente nelle culture del nostro pianeta. Perderlo sarebbe perdere un pezzo fondamentale della nostra propria cultura.
Distruggere per sempre l’essere più selvaggio che ci circondi equivarrebbe a distruggere alle radici la nostra stessa civiltà.
Uccidendo l’ultimo vero avversario naturale, l’uomo dovrebbe fare i conti con il proprio irrefrenabile atteggiamento rapace e distruttivo.
Finalmente, specchiandosi nel profondo archetipo che stava per estinguersi, per la prima volta in millenni l’uomo ha iniziato a sentire di diventare il proprio peggior nemico, come era stato predicato secoli fa da San Francesco nell’Appennino e da Milarepa nello Himalaya.
Come credono gli Indiani Ojibwe (con grande cognizione ecologica ante litteram) qualunque cosa succeda ai lupi poi succede anche agli umani: il destino insondabile dell’uomo è legato al destino del misterioso lupo.
Salvando i lupi l’umanità salva sé stessa: proteggerli rappresenta la possibilità per noi umani di evitare di diventare un flagello globale e di tornare invece ad essere una specie che prospera in equilibrio con le altre.

————
Nota sull’ibridazione
Il cane ha respinto il lupo fuori dalle mura di Roma, ma che senso avrebbero quelle mura senza il lupo? Oggi il mondo comincia ad andarci stretto, l’umanità si chiude in casa solo in caso di pandemie. Aria condizionata, acqua clorificata, cibo precotto, terra cementificata stanno diventando sempre più costrizioni fastidiose a cui sfuggire nel week end. Chi non sogna di bere da una levissima fonte di montagna? Di respirare a pieni polmoni l’aria ricca di una foresta? Di nutrirsi di ricotta appena munta? Di camminare a piedi scalzi su un prato fiorito?
La leviatanica civiltà moderna ha conquistato il mondo materiale ma non la sua anima, né l’anima dell’uomo, irriducibilmente selvaggia. Costretti entro i confini armati dei Parchi, i lupi sono sopravvissuti perché l’uomo sa di aver bisogno di loro e ora loro stanno recuperando terreno.
Oggi quando lupo e cane entrano in contatto a volte invece di scontrarsi si amano. La loro prole ibrida vede l’uomo con un nuovo sguardo. Uno sguardo privo dei terrori inconsci di trappole, fucilate ed esche avvelenate. Così il gene del lupo si avvicina alla città e comincia ad esplorarla. Remo attraversa il solco tracciato da Romolo e non viene pugnalato.
Forse, ora che Google Earth ci rivela che non c’è più alcun luogo ignoto sulla Terra, il mondo frammentato in confini e mura di cemento sta perdendo senso. Forse il solco tracciato da Romolo oggi è obsoleto, bella archeologia. Forse è giusto mantenere dei geni del lupo puri, ma come oggetto museale pro memoria posterorum. L’abbraccio tra Romolo e Remo non può essere negato perché è naturale, più naturale di un lupo in uno zoo e un cane in catena. L’ibrido fra un cane e un lupo sembra la rinascita della lupa archetipa che 14.500 ebbe due cuccioli che scelsero strade divergenti, quella del canis canis e quella del canis lupus. Forse è tornata a noi la madre di un mondo post-civico, un mondo rispettoso della sacralità originaria della terra e della assoluta interdipendenza delle specie viventi. Un mondo regolato in modo più fine e naturale di quello della proprietà privata.
L’ecosfera è sempre stata e sempre sarà capace di riequilibrarsi malgrado l’uomo, e forse come in questo caso anche creando ibridi capaci di attraversare vecchie mura inutili.









Commenti